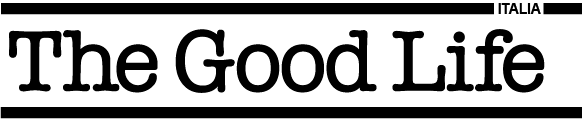La rivincita delle Architette, con Lina Bo Bardi
Il 2021 ha premiato Lina Bo Bardi, insignita a Venezia con il Leone d’Oro Speciale alla Memoria e protagonista del libro La dea stanca. Vita di Lina Bo Bardi (Zeuler R. Lima, ed. Johan & Levi). Combattente e combattiva, decisa a realizzare i propri ideali in forma di spazio da abitare, Bo Bardi è stata un architetto straordinario, soprattutto nel Brasile dove ha vissuto l’epoca più prolifica della sua vita creativa. Un riconoscimento tardivo, certo, per una donna che ha cominciato a lavorare nell’Italia del Dopoguerra, mettendo a segno collaborazioni con Bruno Zevi, Marcello Piacentini, Gio Ponti, per poi scegliere il Brasile con il marito Pietro Maria Bardi. Arriva in un momento particolare, quando si sta sviluppando un altro guardare, un paradigma al femminile che potrebbe rivoluzionare quello patriarcale in cui siamo cresciuti.
> Leggi anche: Intervista a Rana Salam: «Così ho reso il Libano attraente agli occhi del mondo»
Parla il biografo di Lina Bo Bardi
«Lina era un Achille», commenta il suo biografo, alludendo al nome di battesimo della “dea stanca”, Achillina, «Ma la sua vita è stata un po’ quella di un Ulisse. Entrava e usciva da questi ruoli, negoziava per vincere. Ed è morta con qualcosa di Achille: si è rotta la caviglia, infatti, e un pezzettino di osso è entrato nel suo sistema circolatorio…». Dirompente, come la sua storia: dal lavoro divulgativo sulle riviste italiane, alla creazione del Masp, un avveniristico museo sospeso in vetro e cemento lungo la Avenida Paolista di San Paolo, o i successivi progetti per Salvador de Bahia. Si premia una regina dell’architettura, disciplina ancora oggi molto maschile agli occhi di chi non ne fa parte. Si chiede Lima: «Bo Bardi ha vissuto un mondo molto più maschilista di oggi e credo che per una donna piena di ambizioni arrivare dove è arrivata abbia significato fare molti compromessi. Ma ce ne preoccupiamo soltanto perché è una donna: perché non ci chiediamo cosa fanno gli uomini per trovare il loro posto nel mondo?».
La domanda fa eco tra le proposte attuali su una ormai necessaria svolta verso una “città delle donne”, incentrata sul “prendersi cura”: «Un valore forte perché riguarda la cura di sé, degli altri, delle istituzioni, della dimensione collettiva e dello spazio. Per entrare in relazione con gli altri in un rapporto dialettico», spiega Laura Fregolent, docente di Pianificazione urbanistica allo Iuav di Venezia. Non diversamente, Paola Viganò, architetto, urbanista di fama internazionale e professore a Venezia e Losanna, secondo la quale l’urbanistica attuale e futura è fatta di relazioni: «La questione più importante oggi non è tanto immaginare una città diversa, ma la metamorfosi del substrato esistente. Dovremmo guardare a questo con occhi rivolti alla cura, per prenderci cura di quello che già esiste».

Nella casa de vidro, san paolo, 1991.

Lina Bobardi nel cantiere del museo de arte de são paulo, nel 1965 circa.
«Quella del tessuto è un’arte della donna, e su questo abbiamo la supremazia»
Un tema fondante e creativo che emerge in un momento in cui la città ha smesso di essere un luogo da abbandonare o da consumare, per diventare pienamente uno spazio da vivere. Così Benedetta Tagliabue, fondatrice dello studio Miralles Tagliabue, tra i più apprezzati a livello internazionale, parla del modello “femminile” come chiave di lettura universale e necessaria di un’architettura tessuta: «Tessere gli elementi è un’idea che viene dalla partecipazione di tutti. E poi, quella del tessuto è un’arte della donna e su questo abbiamo la supremazia». È notizia recentissima quella della presenza di Laura Ricci, professore e direttore del dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura all’Università La Sapienza di Roma, nella squadra che dovrebbe scrivere la legge sulla rigenerazione urbana del ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini, tra le poche figure femminili presenti nella stanza dei bottoni dell’urbanistica. I ruoli apicali nelle istituzioni, politiche e amministrative, sono ancora poco frequentati da donne; e se i loro progetti hanno più fortuna all’estero che in Italia, è abito diffuso, dice Tagliabue, avere scarsa fiducia nelle capacità di una donna di costruire rispetto a quelle più muscolari di un uomo. «Nel 2017 abbiamo dato il premio Pritzker allo studio RCR di Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramón Vilalta», racconta l’architetto, membro della giuria di questo come di altri prestigiosi premi internazionali, «Naturalmente, a parlare bene l’inglese è Carme Pigem ed è lei, quindi, a tenere la conferenza per la premiazione, davanti all’Imperatore e all’Imperatrice del Giappone. Ebbene, il suo discorso ha mandato letteralmente in estasi l’Imperatrice: proprio lei, emblema della donna che istituzionalmente deve farsi trasparente rispetto al consorte…». La prima donna insignita del Pritzker, d’altronde, è stata Zaha Hadid nel 2004: 25 anni dopo la sua istituzione. E ancora oggi è l’unica con il duo Yvonne Farrell e Shelley McNamara, insignite nel 2020, a non condividere il premio con un partner maschio: «Non diamo spazio alle donne, ma sono in corso cambiamenti interessanti», continua Tagliabue, che coglie anche segnali di stile: «Se prima le studentesse di Architettura portavano pantaloni e capelli corti imitando un modello maschile, ora abbiamo premiato Kazuyo Sejima, Pritzker 2010 con Ryūe Nishizawa, che ama i fiorelloni ed esalta il suo rimanere un’eterna bambina».
Il genere nell’architettura
Ma si può parlare di “genere” nell’architettura? «In questo senso il premio a Bo Bardi è arrivato tardivamente: non tanto perché è donna, ma perché è stata un architetto eccellente», commenta Fregolent. Perché? «La sua è un’architettura del possibile, non d’imposizione, che nasce cercando il materiale, anche umano, nella realtà», spiega Lima. Che si spinge a offrire un’interpretazione psicanalitica del Masp: «Il suo museo a San Paolo è un volume vuoto orizzontale in Avenida Paolista, costellata di grattacieli. Simboli fallici, in cui irrompe un’espressione uterina di uno spazio sempre incinto, perché generoso e accogliente. Lina era una donna penetrante: in lei i generi si mescolano».
E se per Viganò il termine architetto andrebbe inteso in un senso neutro, comprendendo una vasta gamma di declinazioni possibili del fare e pensare l’architettura, va anche sottolineata la scarsità di donne architetto che lavorano in prima persona, nonostante l’aumento esponenziale, negli ultimi venti anni, di studentesse: «L’emancipazione, invece, dev’essere complessiva e proseguire insieme a quella della città», spiega; «per questo occorre fare una battaglia nel senso del neutro, in nome di un’educazione al rispetto». Magari la sposerebbe anche Lina Bo Bardi, che detestava le etichette, nel costruire cercava un senso sociale e nel suo essere architetto un’espressione dell’intellettuale organico. Quello gramsciano, sì.
Per abbonarti a The Good Life Italia, clicca qui.