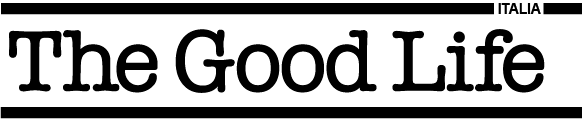La riscossa della cucina africana
Black cuisines matter, e qualcuno finalmente se ne sta accorgendo. Soggetti per decenni a pregiudizi e oblio, relegati in alcuni quartieri delle grandi città europee, sradicati e privati delle loro materie prime (dal nome suadente e misterioso – okra, fonio, detarium, safu, okok – e dalle proprietà meravigliose), ora per i ristoranti africani sembra arrivato il momento della riscossa e della riappropriazione – debita – delle proprie origini. Negli ultimi anni alcuni hanno anche scalato le vette dell’alta ristorazione europea.

piatto di anthony sarpong

la chef congolese victoire gouloubi: prima executive chef donna nera nel nostro paese, ha creato l’evento uma ulafi.
Ribaltare la prospettiva
I protagonisti di questa ondata sono professionisti giovani, creativi, agguerriti il giusto, anche ironici. E con una missione: ribaltare la prospettiva che vede l’Africa come un continente povero di risorse e di culture gastronomiche. E la “paludata” Michelin si è accorta di loro, elargendo una manciata di stelle. «Nel mio ristorante vedi i clienti, anche milionari, che mangiano il cibo con le mani, è pazzesco!», ci dice Anthony Sarpong. Il suo ristorante, Anthony’s Kitchen a Meerbusch, in Germania, ha ottenuto una stella rossa e la stella verde. «Applico le tecniche della gastronomia francese alla cucina del Ghana, da dove vengo. Mi preoccupo della salute dei miei ospiti tanto quanto del loro divertimento. Le risorse naturali, la stagionalità e la conservazione degli equilibrii naturali rappresentano la priorità» dice Sarpong, toccando un tema importante, quella attenzione alle proprietà salutari degli ingredienti che accomuna lo “stellato” al ristorantino dietro l’angolo. E sì che c’è ancora chi pensa che la cucina africana sia “strana” e insalubre. Dimenticando che la cambusa del continente “nero” è ricca di più che potenti superfood. Georgiana Viou guida la cucina di Rouge, ristorante di Nimes in un hôtel particulier del XV secolo. Autodidatta, fonde magistralmente e senza timori le influenze mediterranee della Francia del Sud con le sue radici beninesi, che emergono per esempio nella dja, una sorta di ketchup a base di pomodori e spezie che ha contribuito a popolarizzare in Francia. Avrà sollevato più di un sopracciglio il nuovo “cocco” della cucina francese, il maliano-senegalese Mory Sacko, quando è apparso nel più nazionalpopolare dei talent show culinari, MasterChef Italia. Lui ha aperto il suo ristorante parigino, MoSuke, nel difficile 2020, ma le difficoltà sono durate poco. Ha entusiasmato da subito la sua cucina dalle radici africane con influenze nipponiche e francesi, dove il sushi è fatto con l’attiéké, una semola di manioca, e il miso è autoprodotto con fagioli dall’occhio africani. L’anno scorso è atterrato sulla copertina di Time come capofila delle 100 “stelle nascenti” della scena globale. «Gli chef della mia generazione viaggiano in tutto il mondo scambiandosi idee» dice Sacko, che intanto sta costruendo un piccolo impero: dopo avere aperto Mosugo, comfort food da asporto, ha scelto la residenza ottocentesca del marchese de La Fayette per proporre una cucina “liberamente francese e neo-borghese” (sic). Il suo non è il solo caso di successo istantaneo. Dopo lunghi anni in cui aprire un ristorante africano voleva dire subire continue ispezioni e vessazioni (come racconta la prima generazione dei cuochi africani nel docufilm We Food di Victoire Gouloubi ed Egle Pappalardo), oggi la “stella” arriva anche a pochi mesi dal primo ordine. È il caso di Chishuru, miglior ristorante per Time Out nel 2022 e stella Michelin nel 2023, fondato a Londra da Adejoké Bakare, nigeriana con le idee chiare: «Siamo all’avanguardia nella cucina dell’Africa occidentale, ma c’è ancora molto da fare. Certo, essere un ristoratore e uno chef indipendente è incredibilmente liberatorio. Fai tu le regole, non rispondi a nessuno. Come chef donna di colore non sono sicura che avrei potuto farcela in altro modo», ha detto al Guardian. Il 2023 è stato l’anno della stella Michelin (che definisce il suo riso jollof “da urlo”) anche per un altro indirizzo londinese, Akoko dei nigeriani Aji Akokomi e Ayo Adeyemi (nato in Uk). Se il ristorante è un punto d’arrivo, c’è chi sperimenta nuovi modi di portare la cucina africana al resto del mondo, incrociandola con la cultura e le tradizioni ma anche l’artigianato e i prodotti, unici, del continente. Fatmata Binta, chef nata in Sierra Leone, s’è inventata Dine on a Mat, ristorante nomade che “viaggia” tra Africa, Usa ed Europa, nato per dimostrare come mangiano e interagiscono con il cibo le donne Fulani, etnia nomade diffusa dalla Mauritania al Camerun. Victoire Gouloubi, congolese, viene dall’alta cucina (è stata la prima executive chef donna nera in Italia) e ha ideato Uma Ulafi, evento che coinvolge non solo cuochi afrocaraibici (a maggio è stata la volta di Fati Niang, creatrice della catena di street food senegalese Black Spoon), ma anche artisti, attivisti del clima e imprenditori. «Molti finanziatori ora credono e investono nella gastronomia africana, però in Italia siamo alla preistoria», ci ha raccontato.

chishuru, sempre nella capitale inglese.

mory sacko, chef di mosuke (parigi)

incrocia africa occidentale e giappone.
Anche qui da noi qualcosa si muove
E in effetti nel nostro Paese siamo ancora agli inizi, anche se qualcosa si sta muovendo. A Milano solo nell’ultimo anno hanno debuttato tre ristoranti con radici nell’Africa subsahariana. Siamo andati a visitarli per capirne di più. Abbiamo trovato piatti tradizionali, non siamo ancora alla contaminazione, «l’importante ora è far conoscere la nostra cultura», ci hanno detto. Così la musica di Viviane N’Dour suona in sottofondo, i bellissimi tessuti camerunensi ndop, blu e bianchi, arredano e l’accoglienza è calda; l’attesa, lunga. Una prova zen per l’imbruttito milanese, che se poi arriva tardi in ufficio va a sfogarsi su TripAdvisor. Ma per chi è curioso e aperto verso sapori e consistenze nuove, che spesso virano al dolce (il platano, il succo di baobab) il viaggio è assicurato. Da Laakam, camerunense, c’è il pollo Dg, che sta per directeur général perché – con suprema ironia popolana – quando nacque negli Anni 80 chi poteva permettersi di mangiar carne aveva un buon lavoro, e magari si dava pure arie da Dg. «Oggi si trova ovunque in Camerun», ci dice Jimmy. «Quello che manca alla nostra cucina è la capacità di vendersi, di raccontarsi: quando ero piccolo tutti sapevamo che la pizza o le lasagne venivano dall’Italia, quando parlo di cucina camerunense nessuno sa cosa significhi». Rodrigue Demmasse, uno dei proprietari, mostra fiero le maschere esposte all’interno: «La nostra cucina è identitaria, abbiamo i piatti del Camerun ma anche altri più noti, il mafé dal Senegal e lo zighignì dall’Etiopia, che i clienti italiani già conoscono», ci dice con un’aria da intellettuale di altri tempi. Da Malaika (“angelo” in swahili, ma anche titolo di una straziante canzone d’amore portata al successo da Miriam Makeba), due sorelle del Camerun in un locale a due passi dal lussuosissimo Château Monfort propongono deliziosi antipasti, una birra locale strepitosa e, su ordinazione, il sontuoso ndole royal. «Abbiamo aperto perché ci piace cucinare», dice Michelle: semplice e diretto. Tra le nuove aperture c’è anche Teranga, senegalese. Bamba, in società con il cugino, fa la spola con Parigi, dove ha un negozio di alimentari, e propone yassa di pollo e thieboudienne con riso rosso o bianco, ma anche un delizioso succo di detarium. «Qui non è come in Francia, dobbiamo farci conoscere, le bollette sono alte ma ci proviamo». Piano piano. Scalando pregiudizi e ignoranze. Perché la cucina è la strada maestra per avvicinare le culture. Poi un giorno arriva la “stella”. E ci si chiede perché non ci avevamo pensato prima.