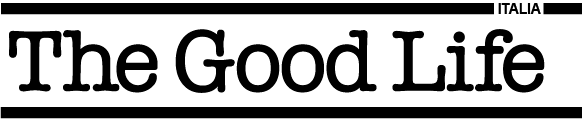Intervista a Paolo Cognetti, tra racconti di pastori e memorie himalayane
«Abbiamo della legna da accatastare. Ci dai una mano?». Se vuoi parlare dei massimi sistemi con Paolo Cognetti, te lo devi guadagnare. Per fortuna, mi ero preparato. E prima di risalire in moto la valdostana Val d’Ayas fino a Estoul, dove lo scrittore ha appreso il lessico familiare del romanzo Le otto montagne, con cui ha vinto il Premio Strega, avevo infilato nello zaino un paio di scarponcini. «Scarpe da lavoro!», commenta soddisfatto Gabriele, detto “Rambo”, l’amico che insieme a Remigio compone il comitato d’accoglienza che, in principio un po’ diffidente, mi attende attorno al tavolo del bar.
“Rambo” ha barba e capelli crespi e rossicci, con qualche spruzzatina di bianco, infilati sotto una fascia copriorecchie. Ha fatto il pastore per una vita, prima di vendere, qualche hanno fa, le sue vacche. Ora lavora alla seggiovia. È imponente e massiccio come i costoni neri di roccia della sua Valle d’Aosta. E anche se i suoi occhi schivi sono gentili, capisci che non è il tipo con cui vorresti discutere per un posto auto.
“In montagna si cammina soli, anche quando si cammina con qualcuno”, avevo letto nell’ultimo libro di Paolo: Senza mai arrivare in cima, edito come il precedente da Einaudi. E Dio sa se non te ne accorgi mentre, disorientato, cerchi di trovare lo sterrato che porta alla baita che lo scrittore ha appena comprato e ristrutturato, insieme al rifugio di cui aprirà le porte il prossimo inverno. Indicazioni stradali fulminee e concise, le loro. Indicazioni di gente di montagna, che afferro appena. Sarebbe poco onorevole chiedere, tuttavia.
Così me la cavo aggrappandomi al mio istinto intorpidito di cittadino. E, parcheggiata la moto sul prato sopra la baita, affronto la catasta mentre Remigio scarica con la benna meccanica la legna ai miei piedi, consapevole che senza guanti, ben presto mi ritroverò le mani piene di schegge. «Da come accatasta la legna, si capisce tutto di un uomo», scherza Paolo, citando non so quale scrittore norvegese. Mi rendo conto, allora, di partecipare a un rito d’iniziazione. Gli rispondo citando dal suo libro, dove racconta il suo viaggio con gli amici Remigio e Nicola tra le valli e le cime himalayane del cosiddetto piccolo Tibet, in Nepal: “Le amicizie non vanno guardate accadere: vanno fondate, costruite, hanno bisogno di imprese memorabili per il futuro”. «A ciascuno la sua impresa», dico. Ride.
Una giornata da ospiti nella baita di Paolo Cognetti
Mentre silente, ma attento, Remigio vigila su inclinazione dei ciocchi e sagoma della mia catasta, il discorso va al loro viaggio tibetano lungo le tracce del Leopardo delle nevi, il libro di Peter Matthiessen, uscito nel 1978 e tutt’ora sui banchi di ogni libreria di Katmandu. A spingere Matthiessen all’inseguimento del più elusivo e misterioso felino del mondo furono gli Anni 70, con le loro promesse mancate.
A quel tempo Matthiessen entrava nella mezza età, consapevole di avere combinato poco. Stanco degli allucinogeni, interessato al buddismo, scrisse dopo quel viaggio il suo best seller. Anche gli anni che stiamo vivendo, tra crisi economiche, politiche e sanitarie, non sono il massimo. Ma non è per questo che Paolo è partito con i suoi amici e ha raccontato il suo viaggio: «Volevo capire se esisteva ancora da qualche parte una montagna autentica, libera dal colonialismo della città. E se esistevano ancora i montanari. Ero già stato in Nepal, anni fa. Avevo visto come la modernità stava portando i suoi doni: strade, anzitutto, e poi motori, energia elettrica, telefoni…». L’ha trovata, gli chiedo? Non proprio. Nel giro di pochi anni, anche lassù, è avvenuta una rivoluzione, rimescolando le carte della storia in modo sconcertante. Ne parliamo in una pausa dalla legnaia, insieme a Remigio e Rambo, nella trattoria di Barbara, che trent’anni fa si è trasferita a Estoul da Milano.
La prima a colpire è la storia di Sete, lo sherpa nepalese che ha organizzato la loro carovana: quarantasette membri tra animali e uomini. «Dapprima cuoco, quindi portatore d’alta quota, Sete si è caricato la gerla sulla schiena fin da ragazzino, conquistando “Ottomila” del calibro dell’Everest, del Makalu, del Cho Oyu, del Dhaulagiri, dello Shisha Pangma», s’accende Paolo. Tutte imprese rimaste anonime, come per la maggior parte di questi alpinisti locali, la cui incredibile tempra è messa esclusivamente al servizio della gloria occidentale. Sete è il cosmopolita che non t’aspetti. In estate e inverno lavora nei rifugi del Monte Rosa. In autunno ritorna in patria per accompagnare gli italiani nelle valli himalayane. E la sua storia è il segno inequivocabile di una contaminazione radicale, già preludio di un destino di abbandono della montagna che dalle Alpi si sta trasferendo dove si sperava non potesse arrivare.
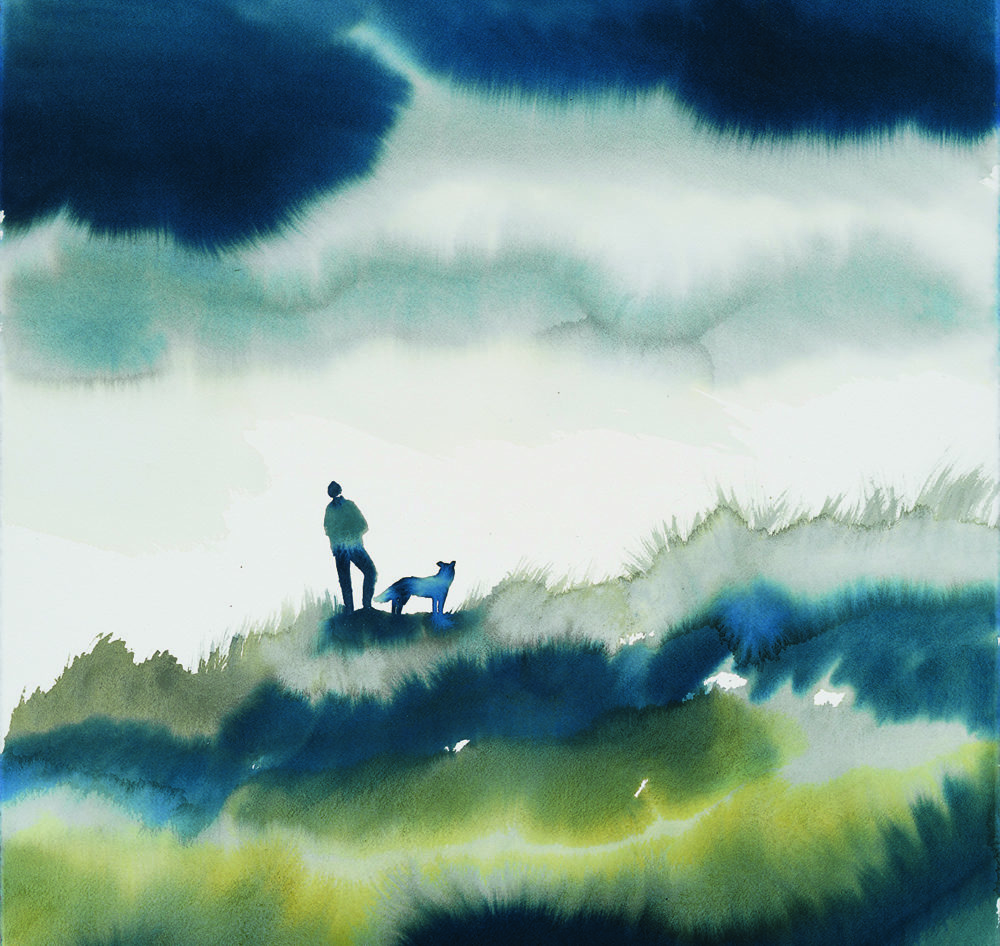
Illustrazioni di Nicola Magrin
Paolo Cognetti e il Tibet
Nessuno come Remigio lo può capire. La lingua della montagna non è alla portata di tutti. Per questo Paolo da sempre ama salire in quota con lui. Per questo lo ha voluto con sé in Tibet. Remigio è nato in un villaggio dove fino agli Anni 70 si saliva a piedi. Poi è arrivata la strada. E il villaggio si è spopolato.
Paolo ricorda: «Una volta mi ha detto: quando la strada arriva sembra fatta per portare qualcosa, poi invece si scopre che è fatta per portare via». Anche in Tibet è così. Te ne accorgi quando, risalendo un fiume per raggiungere un lago a 3 600 m, un camioncino ti supera sulla sterrata e i portatori ti rivelano che solo poco tempo fa, lì, c’era una mulattiera. Eppure, prima che l’alta quota diradi la vegetazione, le risaie, le balze coltivate a orzo e miglio, gli orti, i cumuli di fieno e il peperoncino distesi a essiccare sui tetti delle case in terra battuta, parlano la lingua di una montagna che ancora è viva, lontana da quella con la quale si esprimono i muretti a secco diroccati, le terrazze invase dagli sterpi, i canali inghiottiti dai boschi che s’incontrano lungo i crinali delle nostre Alpi.
Ma è difficile condividere la meraviglia con chi è nato nelle valli himalayane. Ammirati, Paolo e Remigio ci raccontano di donne, ragazzini e ragazzine che, con la gerla sulle spalle, hanno visto risalire pendii a 3 000 m di altitudine, infradito ai piedi. E di mulattieri appena ventenni che affrontano come se passeggiassero nel quadrilatero della moda milanese i 4 000 m, chiedendosi che cosa mai spinga quelle strane creature che sono gli occidentali ad ammazzarsi di freddo e di fatica, infagottati come samurai, ad attraversare a piedi le loro montagne. La domanda aleggia ovunque, anche quando non viene formulata. «D’altronde, forse non saprei dare una risposta comprensibile», confessa Paolo Cognetti. Tutto quello che per noi occidentali è strano, per loro è normale. E viceversa. Così ti ritrovi a stupirti quando gli stessi ragazzi che di giorno sembrano appartenere alla montagna non meno delle acque che scendono dai ghiacciai, dell’aria che ti gela i polmoni, degli yak che solcano le pianure, la notte si raccolgono attorno al fuoco per ascoltare e ballare la trap dai telefonini, come potrebbero fare in un qualunque sobborgo di New York, Parigi, Shenzhen o Tokyo. Non meno sconcertante, d’altronde, è vedere ovunque al lavoro quasi soltanto le donne, nei campi non meno che lungo le mulattiere: «Donne giovani che battono l’orzo con lunghi bastoni, donne anziane che lo setacciano per ripulirlo della crusca, donne che tagliano l’erba con falcetti sottili mentre i bambini formano catene umane per portare loro il refrigerio dell’acqua del torrente più sotto». Chiedo a Paolo e Remigio dove fossero gli uomini. Si mettono a ridere: «Probabilmente a giocare d’azzardo nella sale che spuntano a fondovalle». Strade, motori, elettricità, telefonini, tavoli da gioco: la marcia del progresso.
D’inverno a Milano, d’estate in montagna: Paolo Cognetti e l’arte della transumanza
Se Remigio è l’interprete della montagna, capace di leggere in un crinale affilato o in un canalone scavato da una frana la storia di una valle e il suo sedimento umano, Rambo è la montagna stessa: la sua forza, la sua resilienza, l’intelligenza delle cose che nessuna scienza cittadina ti può dare. Ma anche la sua malinconia. Concluso il lavoro alla legnaia, lo raggiungiamo a piedi fino alla sua baita. È un viaggio nel tempo, che carburiamo con vino rosso forte, i gomiti appoggiati a un tavolo di legno pesante, circondati dalla sua collezione di campanacci dalle dimensioni gigantesche. I più antichi li ha ereditati dal padre, che li ha ereditati dal nonno.
Lì, in una stanza grande la metà di un monolocale, con il bagno e la vasca all’aperto dove si raccoglie l’acqua che scende dalla montagna, ha dormito per anni con la madre e le sorelle: «Sopra il fieno, sotto le mucche, in mezzo noi», racconta sornione, indovinando di parlare con uno che senza una termocoperta d’inverno non sopravviverebbe una notte ad Alassio. Non è necessario volare alle pendici dell’Himalaya per cogliere le contraddizioni del nostro tempo.
Mentre la pandemia mette in ginocchio la vita urbana, le sue folle, le sue frenesie, spingendo molti a coltivare il sogno di una vita nuovamente a contatto con gli spazi aperti e ritmi lenti e cadenzati della natura, Paolo Cognetti nota che la bottiglia d’acqua con la quale ci sciogliamo la lingua viene da una sorgente che sta 1 000 m più in basso della nostra montagna: «Pensa al viaggio che ha fatto, all’energia che ha richiesto, all’inquinamento che ha prodotto, mentre in montagna si canalizzano, si cementificano e si prosciugano fiumi e falde per soddisfare i consumi turistici. E pensa a quello che ogni giorno, su e giù per le valli, producono i nostri trasferimenti per studiare, lavorare, trasportare merci».
Si arriva così al paradosso per cui, per garantire uno stile di vita “urbano” ovunque uniforme, le nostre città energivore e trafficate risultano a conti fatti più ecosostenibili delle campagne e delle montagne dove talvolta vorremmo tornare a vivere per riconnetterci con la natura. Anche per questo, come il protagonista di Le otto montagne, Paolo ha coltivato e continua a coltivare l’arte della transumanza: sei mesi invernali a Milano, sei mesi qui. Ma non gli basta: «Ho pubblicato il mio primo libro a 25 anni. Benché le mie pubblicazioni avessero un riscontro, però, soltanto dopo lo Strega alla domanda su quale sia il mio lavoro, riesco a rispondere: “scrittore”. Perché non devo più fare il cuoco o altri mestieri per vivere».
Arte, musica, libri e teatro nei boschi
Scrivere, tuttavia, non è tutto. «Dopo lo Strega, qui a Estoul, con alcuni amici abbiamo lanciato un festival: “Il richiamo della foresta”, un omaggio al romanzo di Jack London». Nasce per portare arte, musica, libri, teatro, fotografia nei boschi. Ma anche un’idea di vita che Paolo Cognetti e i suoi amici si ostinano a chiamare “politica”. La montagna è presentata, nel primo manifesto del festival, come “occasione di libertà e bellezza” da non ridurre a dépendance della nostra stressante vita di pianura, spazio ludico artificializzato funzionale solo allo sfruttamento economico.
La conoscenza, la memoria della montagna, legata anche a mestieri come quello di Rambo, oggi si perdono o sopravvivono a volte solo nel lavoro nelle baite e negli alpeggi di stranieri: albanesi, prima, ora rumeni. Ma per quanto ancora? «Eppure la montagna, come tutti i bordi, i margini e le periferie del mondo sono i luoghi che più dovremmo coltivare, perché sono i più fertili, tolleranti e aperti all’incontro», riflette. Non si tratta soltanto di salvaguardare un ambiente naturale, bensì di alimentare un paesaggio spirituale e una forma di vita comunitaria alla quale Paolo Cognetti ciclicamente deve tornare pur essendo figlio della città, bisognoso di tenerla viva come una seconda possibilità.
Lo confessa mentre diamo a Rambo appuntamento per una prossima bottiglia e, tra le mucche, torniamo piano alla sua baita. Tra poco calerà il sole. La pianura mi richiama. Ma non richiama solo me. Pochi giorni e le mucche lasceranno l’alpeggio e cesserà, con la loro presenza, il dolce mormorìo dei campanacci. Tutto allora diverrà silenzio, un silenzio abissale, che dura fino all’inizio dei fragori effimeri della stagione sciistica, quando la montagna non sembra più neppure lei. È tempo di tornare in città.