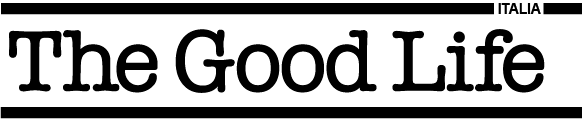Il formidabile Bolaño, un po’ miracolo e un po’ kamikaze
Tempo di anniversari per Roberto Bolaño, uno di quei rari casi di scrittori che riescono sia a parlare al pubblico colto e a innovare la letteratura sia a raggiungere la massa dai lettori, diventando in un certo senso dei fenomeni di costume. Forse il paragone più sensato che si può fare è con David Foster Wallace, lo scrittore americano che ha dato una voce unica agli anni Novanta e ha riportato l’attenzione sui romanzi-mondo, come il suo Infinite Jest. Bolaño però, pur essendo diventato anche autore di culto, è stato più accessibile, ha costruito la sua letteratura – sfruttando la lezione magistrale di Borges – attraverso libri e autori apocrifi e con la scusa di raccontare le loro storie e le loro trame ha raccontato qualcosa di nuovo. Le sue storie e le sue trame. Giocando una partita talmente onesta con il mainstream da sembrare a volte incosciente. Il suo storico editore spagnolo, Jorge Herralde, lo ha descritto come un «kamikaze e con la testa sotto la sabbia» e la definizione, nella sua ambivalenza, si adatta alla biografia di un uomo che ha convissuto a lungo con la malattia come pure alla bibliografia di uno scrittore che ha cercato di indagare tutte le malattie del mondo, da quelle politiche (come la dittatura) a quelle sociali (come la violenza e l’amore).
Tempo di anniversari, si diceva. La ricorrenza infatti è duplice. Nato a Santiago del Cile il 28 aprile 1953, Bolaño è morto vent’anni fa, il 14 luglio del 2003 a Barcellona in attesa di un trapianto di fegato, rinviato per via della stesura del suo monumentale capolavoro postumo 2666, e alla fine mai avvenuto. Oggi avrebbe 70 anni, un’età che probabilmente farebbe di lui una sorta di padre nobile della letteratura contemporanea, qualifica che – ne siamo certi – avrebbe rifiutato con determinazione, convinto che, come ha detto in un’intervista a Playboy poco prima di morire, «il mondo è vivo e tutto ciò che è vivo è irrecuperabile e questa è la nostra fortuna». Di spazio per le lezioni, in questa irrecuperabilità, non sembra essercene molto, eppure i suoi libri sono oggi a tutti gli effetti una lezione, sia formale sia di urgenza nella scrittura: sono testimonianze del nostro tempo. Perché se è indubbio che per tutta la sua vita Bolaño ha scritto libri che si camuffavano sotto le vesti del giallo o del noir (basti pensare al titolo di uno dei suoi capolavori, I detective selvaggi, che ha avuto un incredibile successo negli Stati Uniti e nel 1998 ha portato a Bolaño cinque anni di celebrità mondiale) oppure ha finto di raccontare le bibliografie altrui (ne La letteratura nazista in America, libro di visionaria brillantezza segreta), è altrettanto indiscutibile che ha saputo infondere «nella letteratura tutto il carico della vita; tutto il rimorso umano di fronte ai fardelli della vita personale o alla coscienza della storia». Parola di Jonathan Lethem, grandissimo scrittore americano, che ha aggiunto che la forza di Bolaño sta nello «sfidare la narrativa tradizionale con una noncuranza torrenziale».
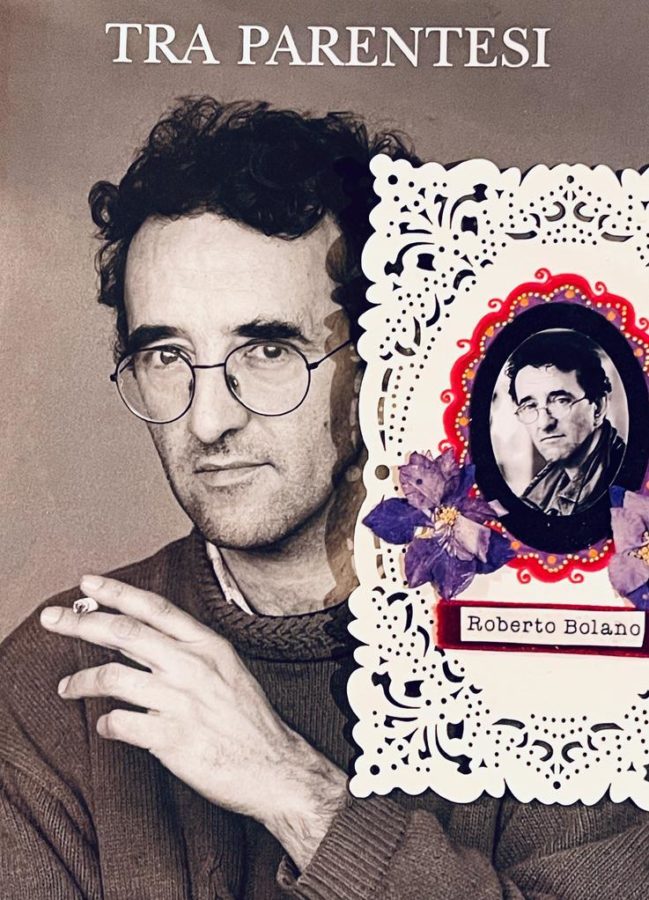
E torrenziali sono I detective selvaggi, romanzo costruito intorno alla vicenda di due giovani poeti, Ulises Lima e Arturo Belano, che aderiscono al gruppo realvisceralista e vanno in cerca di Cesarea Tinajero, la leggendaria fondatrice dello stesso movimento. Una vicenda on the road, che per gran parte delle oltre 700 pagine del libro viene però raccontata attraverso una serie di interviste a personaggi che hanno in qualche modo incontrato Lima e Belano osservando la loro ricerca da una prospettiva come minimo laterale. Insomma: con la noncuranza di cui diceva Lethem, Bolaño aveva ribaltato il tavolo della struttura del romanzo contemporaneo e lo aveva fatto venendo letto, tantissimo e ovunque. Probabilmente grazie anche alla mai sopita vocazione punk della sua scrittura e all’abilità di avere inserito una linea di racconto profondamente classica (come quella della ricerca di una specie di santo Graal) in un contesto vivo, reale, «una calda vicenda di uomini e donne, ragazzi e ragazze», ha scritto Nicola Lagioia. Si aggiunga poi l’abilità di usare tanto i trucchi del mestiere (dalla suspence a una voluta oscurità) quanto ammiccamenti e sensualità, e il gioco è fatto. Il rizoma della sua scrittura, così fitta di intrecci e di rimandi, così articolata da muoversi attraverso tutti i libri (spesso la risposta a una domanda sollevata in un romanzo la si trova in un altro, a esso non necessariamente collegato), si scioglie nell’umanità, nella comune sconfitta, nell’ammissione che il dolore del mondo non è gestibile. Ma può diventare una poderosa letteratura. Questo, a ormai 20 anni dalla morte, resta il miracolo incurante di Bolaño.
E il discorso vale, forse ancora di più per 2666. Anche qui una ricerca, anche qui uno scrittore: l’invisibile Benno von Arcimboldi. Anche qui dei cercatori: quattro critici europei studiosi dell’opera dell’inafferrabile tedesco. Ma intorno, tutta l’esplosione – e ci torna in mente David Wallace – del mondo e dalla sua disperata follia, riassunta dal buco nero che sta al centro del romanzo: la storia dei femminicidi di Santa Teresa, in Messico, ispirata a quanto accadeva realmente a Ciudad Juarez. Per centinaia di pagine, Bolaño descrive con linguaggio autoptico il ritrovamento nel deserto dei cadaveri delle donne. Per centinaia di pagine, si esercita (e ci esercita) a guardare in faccia l’orrore. E come accadeva a Ungaretti in guerra, la conseguenza è di sentirsi, come non mai, attaccati alla vita; attaccati alla letteratura che riesce a fare anche questo. Solo un kamikaze poteva farlo, è chiaro, e solo un uomo che aveva dato tutto alla letteratura poteva scegliere di farsi guidare in questo abisso da una guida come Arcimboldi, lo scrittore che non c’era. Forse il paragone con Dante è spericolato, ma in bilico tra questi due anniversari magari possiamo permettercelo, come se fosse un regalo.