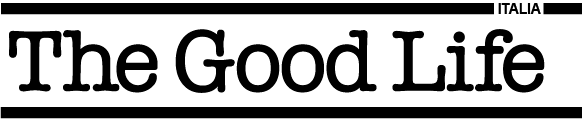Honjok, Nuove tribù globali
Non parlo una sillaba di coreano, ma alcune sue parole mi scovano e mi raccontano. Termini stretti, con dentro un mondo largo, che descrivono abitudini ed emozioni. Sono un honbap e un honhaeng, un honnol e un honsho, a dirla tutta anche un honsul e un honyeong. Nell’ordine, vuol dire che mangio spesso in compagnia di me stesso, viaggio di frequente in autonomia, nella medesima maniera trascorro una parte non trascurabile del mio tempo libero. Faccio acquisti da solo, mi concedo un calice di vino davanti a un film o una serie televisiva. Il mio divano conta due posti, l’altro rimane vuoto.
Lo dico subito, non sono per niente depresso. Anzi, ho trovato una forma traballante di relativo equilibrio. Insistendo con le allitterazioni, c’è un vocabolo che sintetizza tutto: sono un honjok. Una tribù di uno. Appartengo alla sfera delle “persone che scelgono volontariamente di vivere per conto loro”, come si legge nel glossario nelle prime pagine del libro dal titolo omonimo.
Già, Honjok. Edito da Vivida, scritto dalla giornalista Silvia Lazzaris assieme all’autrice e traduttrice Jade Jeongso An, illustrato in modo splendidamente fantasioso da Giovanna Ferraris e Francesca Leoneschi, spegne dal sottotitolo qualsiasi bagliore di tristezza. Illustra “il metodo coreano per vivere felici con sé stessi”. Ne enfatizza la ben ponderata intenzionalità. La cascata di consapevolezza e serenità, che ne segue. O almeno dovrebbe. Non siamo nella prigione cupa degli hikikomori (si vede che in Oriente le “acca” iniziali contano eccome), degli eremiti giapponesi, adulti e ragazzi “che si ritirano dalla società e cercano un estremo isolamento”. Non c’è la deriva del rifiuto della collettività, quanto la decisione di viverla a dosi ragionate, secondo i propri ritmi: tuffarsi nel plurale, per ritornare in un più confortevole singolare. Un pendolo tra l’essere e l’esserci. Tra presenza e assenza.
Seul è diventata la capitale mondiale di questo fermento, l’ha reso il superamento di una tradizione collettivista, in cui la soggettività si risolveva nella famiglia, prima quella d’origine, poi quella frutto del matrimonio, caldamente consigliato per non sbandare in una malvista atomizzazione. Solo un tassello di pregiudizio in una cultura in cui i pasti procedono secondo una ritualità che assegna ruoli, deferenze da ricordar alle quali ci si deve obbligatoriamente conformare. Dove vige una schiacciante ansia da soffocamento per le nuove generazioni, che reagiscono scolpendosi l’identità con una silenziosa, autarchica ribellione. Con un carpe diem egoriferito, un cogliere l’attimo facendolo proprio per intero. Fagocitandolo, senza esporlo a interferenze.


Quando sono arrivato in Corea del Sud sono venuti meno gli imbarazzi che provo spesso in Europa, meno negli Stati Uniti. A cena a Parigi o Londra fatico a ordinare perché spesso il cameriere dà per scontato che stia aspettando qualcuno. A New York, San Francisco, Las Vegas o Los Angeles, nessuno si scompone se dichiaro un party of one: al massimo mi viene chiesto di accomodarmi al bancone, se non ci sono tavoli liberi. Gli sgabelli davanti al barista, apparecchiati con tovagliolo e posate, sono fatti apposta. Il suo sorridente, affettato chiacchiericcio, anche. A Seul sono andati oltre: sempre più ristoranti hanno montato separé in legno o dai vetri oscurati a tutela della privacy del posto singolo; le sedie guardano nella stessa direzione, come in aereo, riparando da occhiate indiscrete. La scena si ripete nei cocktail bar, tra tavolini, angolini, diminuitivi assortiti: il riflesso di una rivoluzione nella architettura d’interni.
I supermercati stanno costruendo un business offrendo sugli scaffali porzioni di piccola taglia o confezioni non formato famiglia, che invece obbligherebbero a ingozzarsi per giorni del medesimo alimento per evitare che scada. Pure lo shopping sta vivendo una metamorfosi: nella capitale del K-pop, i commessi sono parecchio attivi, partecipano alle scelte del cliente, gli propongono cosa può stargli bene e, simulando un eccesso di trasparenza, quello che invece no. Celebri centri commerciali, su tutti gli enormi department store e gli outlet del colosso Lotte, distribuiscono adesivi per honjok. Un segnale visivo da appiccicarsi sul petto e sottintendere: “Non mi occorre aiuto, preferisco fare da me”. La tendenza si estende alle vacanze. E qui non occorre chissà quale sforzo d’immedesimazione: volete mettere la libertà di alzarvi e fare colazione quando vi pare, sonnecchiare nel pomeriggio, tirar tardi la sera, passare ore infinite in un museo ipnotizzati dallo stesso quadro, mangiare le peggiori porcherie a orari improbabili? Se viene un po’ di malinconia, basta attaccare bottone. Si tratta di partire senza conoscere ancora i propri compagni di viaggio, suggerisce il libro, ribadendo – è il refrain del saggio – come questa categoria dello spirito sia l’antitesi dell’asocialità.
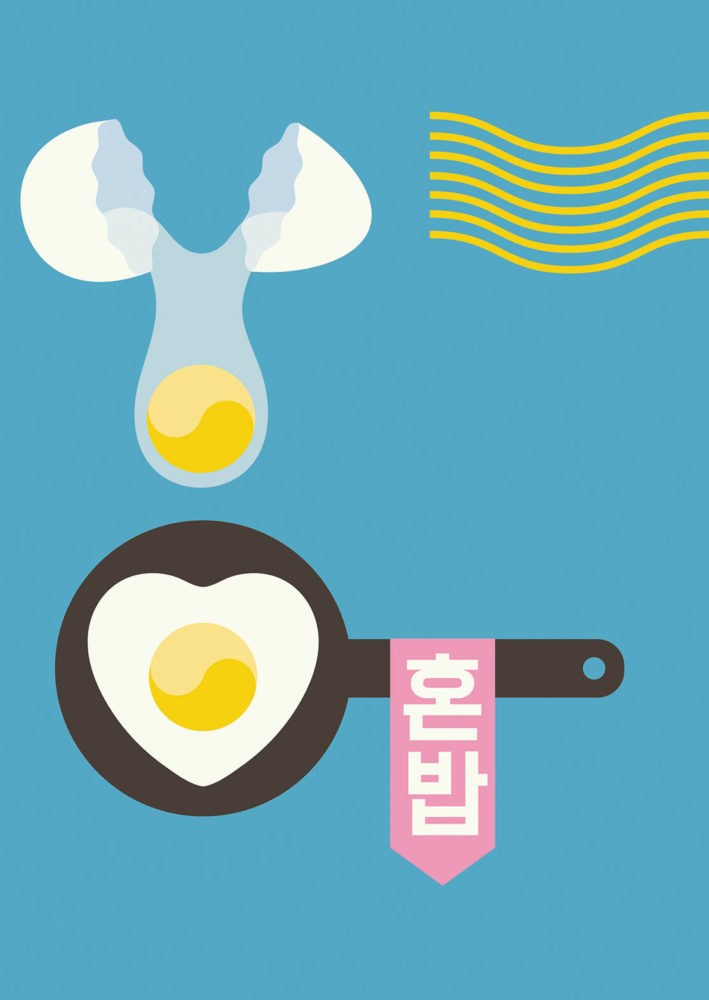

Certo, magari dimostra una particolare predilezione per i social network e indugia in qualche deriva a noi difficilmente comprensibile: per esempio, gli honjok seguono influencer che parlano tra sé allo specchio o si filmano muti durante i pasti, sdoganando l’eccezione per reiterazione. O suppliscono alle mancanze amorose con succedanei affettivi tecnologici, quali aggeggi robotici che danno il buongiorno, il ben tornato a casa, chiedono a intervalli regolari come va l’umore, fingendo di avere a cuore la risposta. Sono un’Alexa più appassionata e calorosa, il film Her di Spike Jonze (in cui un uomo flirta con un’intelligenza artificiale) trasportato nella quotidianità. Senza sconfinare nella distopia, c’è una terminologia anche per questo: parliamo di chosiknam, “uomini che non sono interessati a sposarsi o avere una relazione seria e duratura”. O di geon-eo-mul-nyeo, il loro equivalente femminile. Con tutto lo spettro pensabile: l’astinenza o il libertinaggio, l’asessualità o la moltiplicazione dei partner, schivando lo sgambetto di possibili complicazioni. Di nuovo, una sberla ai codici di comportamento di una tradizione che fa coincidere la stabilità con il passo a due della coppia, la monogamia con l’ortodossia. In Occidente vale meno, però il single a oltranza viene comunque visto con una dose di sospetto, come se portasse addosso una traccia d’incompiutezza.


La strategia, banale quanto ardua, è imparare a fregarsene. Gli honjok, quelli che con fierezza si professano tali, ce l’hanno fatta. “La conquista più grande è quella psicologica”, spiegano gli esperti della nuova tendenza: l’isolamento li ha portati a scoprire che nella solitudine possono trovare pace, che non hanno bisogno dell’approvazione degli altri per sentirsi in armonia con se stessi. Che stare da soli non significa sentirsi soli. Hanno vinto l’incontro di pugilato tra la coscienza personale e la collettiva, hanno zittito lo scontro latente tra l’immagine pubblica e la sfera privata. È qui l’essenza, il metodo proposto dal volume. Un invito a riflettere sul fatto che non c’è nessun problema a prendersi del tempo per se stessi, da usare come un potente antidoto contro quelle norme e abitudini in cui non ci riconosciamo. L’honjok è una rassicurazione, è dirsi: non serve fare quello che fanno tutti, non serve piacere sempre a tutti. Lo scrittore giapponese Yukio Mishima c’era arrivato: “Avevo paura di stare da solo. Ora ho paura di avere le persone sbagliate al mio fianco”.