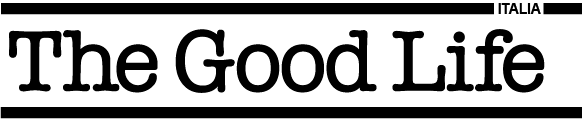Destinazione Cape Town, la città dai molti nomi
Il trucco è sempre il solito. Svegliarsi all’alba, cimentarsi con un’abbondante colazione e arrivare alla partenza della funivia prima che apra. A quel punto, con un po’di fortuna, avrete evitato un’ora di coda – o addirittura un paio, in quelle giornate dal cielo incredibilmente terso che nemmeno il cobalto. Poi, certo, non volendo badare a spese, si può sempre andare online e con un obolo di non più di 50 € acquistare un fast track. Ma non vi darebbe un po’ l’impressione di barare? La salita a quota 1 066 m sul livello del mare richiede invece un poco più di tre minuti, si fila a dieci metri al secondo con la cabina rossa che piroetta su se stessa, elargendo prospettive-cartolina a 360 gradi. Dal lontano 1929 sono saliti a bordo oltre trenta milioni di passeggeri, tutto merito di un tale di nome Trygve Stromsoe, ingegnere norvegese visionario che insieme alla rinomata Adolf Bleichert & Co. di Lipsia, trasformarono in realtà il risultato di un referendum cittadino che si tradusse in un plebiscito: la funivia s’ha da fare. E fu cosi che gli abitanti di Cape Town poterono finalmente salire in cima a Table Mountain sospesi su un cavo invece che sulle proprie gambe, opzione questa tuttora percorribile a patto di essere decorosamente in forma. E che si sappia: in quasi un secolo non si è sfracellata una sola cabina. Table Mountain, la cui sommità è naturalmente piatta come una tavola, non è una montagna qualsiasi, bensì l’attrazione numero uno della capitale del Sudafrica, essendo interamente inclusa nel territorio comunale. E anche per questo risulta essere anche il Parco nazionale più visitato del Paese. Alla voce “flora” rispondono oltre 2 200 specie di piante, a maggioranza fynbos, cespugli endemici protetti dalla Regione floristica del Capo (Cape Floristic Region), che consiste in una striscia di territorio Patrimonio dell’Umanità Unesco, compresa tra la foce del fiume Olifants e Port Elizabeth. La fauna selvatica annovera invece curiosi personaggi come le procavie o iraci – più simpaticamente noti in lingua swahili come pimbi – pelosi e ben pasciuti mammiferi vagamente somiglianti a conigli con le zampe corte: nulla di più facile che vederli spaparanzati al sole o in cerca di snack dalle mani dei turisti.

il porto è la risorsa storica della città.

non mancano spiagge in città: una decina verso sud e una ininterrotta verso nord.
Raggiunta la cima di Table Mountain, l’elenco delle possibilità che si aprono davanti a noi è pressoché illimitato: ci si può cimentare sugli infiniti sentieri – da percorrere a piedi oppure in mountain bike –, sedersi con un libro in mano, anche se va sempre meno di moda, o semplicemente godersi la vista a perdita d’occhio. Si scorge tutta la città (poco meno di cinque milioni di abitanti) e anche parecchio oltre. Ecco, quello laggiù, affacciato sull’Atlantico, è il V&A Waterfront, dove la V sta per Victoria e la A per Albert, ma che tutti chiamano semplicemente “Waterfront”, laddove per “tutti” s’intendono quasi 24 mln di visitatori l’anno, il 23% dei quali è straniero. Già perché quello che un tempo fu il più antico porto a Sud dell’equatore, oggi è uno dei quartieri più trendy del continente. Per raccontarlo, non bastano i numeri, ma possono senz’altro fornire un contesto: 123 ettari di superficie, più di 80 ristoranti, oltre 500 negozi, 12 hotel, una ruota panoramica, un acquario con 8 000 abitanti – pinguini inclusi – e una quantità di bar e di yacht a perdita d’occhio. A rammentare il mondo che fu, è rimasta la vittoriana e gotica Torre dell’orologio (importato nientemeno che da Edimburgo), oggi come allora tinteggiata di rosso, ma ufficialmente in pensione; il capitano del porto ha da tempo cambiato ufficio e l’attenzione generale si è spostata duecento metri più a sud, perché là dove c’era il grano ora c’è lo Zeitz Mocaa.

zeitz museum of contemporary art africa (mocaa), opera dell’architetto inglese thomas heatherwick.
Acronimo di Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, il più grande museo d’arte contemporanea africana del Pianeta è racchiuso in un’armatura di cemento e vetro che pare una base aliena sulla Terra. Gli alieni sono quelli dello studio di progettazione londinese Heatherwick, che in tre anni di lavori 2014-2017 hanno convertito un complesso di quarantadue silos per frumento degli Anni 20 nel “più atteso edificio d’Africa”, come lo definì l’Architectural Digest. Zeit è invece il cognome del signor Jochen, businessman (Presidente e Ceo del gruppo Harley-Davidson), filantropo, collezionista, nonché co-fondatore del museo. Oltrepassato l’atrio, che non sfigurerebbe in Star Wars, si vaga per nove piani emozionandosi di fronte alle opere di Kudzanai Chiurai (Zimbawe), Kadara Enyeasi (Nigeria), Sue Williamson (Sudafrica), Godfried Donkor (Ghana), Banele Khoza (Swaziland… e tanti altri nomi poco noti al grande pubblico occidentale ma, proprio per questo, non c’è luogo migliore, anche in termini di allestimento, dove “incontrarli”. Completano il quadro una lounge-bistrot al sesto piano, uno store dove rifornirsi di libri d’arte e non solo, sale lettura e spazi per eventi. I sei piani sovrastanti il museo sono invece occupati dal più esclusivo hotel di Cape Town, che non poteva chiamarsi che silotheroyalportfolio.com). Ventotto suite di design, nessuna uguale all’altra, nessuna con la stessa palette, ma tutte con una vista senza rivali, e i prezzi non sono da meno. Si parte da poco meno di 1 400 € fino ai quasi 13 000 della penthouse. A notte, naturalmente. Dall’altro lato del porto, eccoci invece arrivare a Woodstock, il quartiere più creativo di Cape Town, anche se quando fu battezzato tale – di Jimi Hendrix e compagnia – nessuno aveva ancora sentito parlare. Correva infatti il 1867 allorché gli abitanti di questo sobborgo alla moda, decisero di abbandonare il nome New Brighton (e prima ancora Papendorp) in favore di quello attuale. Vent’anni dopo, grazie anche al porto e alla ferrovia, Woodstock raggiunse il terzo posto in classifica per numero di residenti tra le città sudafricane. L’attitudine industriale finì per prevalere su quella residenziale e a metà degli Anni 50 spiagge e ombrelloni si erano già trasformati in ricordi. Miracolosamente risparmiata dal diventare una zona per soli “bianchi”, durante il periodo in cui vigeva l’apartheid tra discendenti di colonialisti europei, o Boeri, in prevalenza d’origine olandese, religione protestante, lingua afrikaans – e nativi del Continente, Woodstock è tornata a brillare grazie alla consueta parolina magica: gentrification, un vortice inarrestabile con al centro… ebbene sì, una fabbrica di biscotti (theoldbiscuitmill.co.za)

le “culture” e la storia della città, tra luci e ombre, è inscritta nei suoi graffiti.

una delle sale interne dello zeitz museum of contemporary art africa (mocaa)
Indietro veloce fino al 1862, anno di nascita di John Pyott nella città scozzese di Dundee. Dieci anni dopo era già assistente fornaio, ma una salute non proprio di ferro lo convinse a spostarsi nel più salubre Sudafrica: bingo! La sua carriera nel mondo del glutine non conobbe ostacoli, e nel 1914, al 375 di Albert Road, piazzò una bella fabbrica di biscotti: Romany Creams, Lemon Creams, e Iced Zoo Biscuits diventano marchi noti a tutti coloro che non temono zucchero e calorie. Ma dopo essere stata acquisita dall’americana National Biscuit Company of America negli Anni 70, l’Old Biscuit Mill finisce per arenarsi nell’oblio. Resuscita solo nel 2008, quando riapre i battenti trasformata in hub creativo e culturale, con un’appendice gastro-godereccia di nome Neighbourgoods Market, in onda tutti i sabati dalle ore 9,00 alle 18,00: stand ricolmi di street food, ma anche di artigianato e design, che mica vorrai tornare a casa senza un souvenir. Chi si presentasse all’ex biscottificio negli altri giorni della settimana, troverebbe comunque una quantità di caffè, ristoranti, gallerie e concept store a prova dei più navigati hipster. Senza contare che le vie attorno sono un brulicare di locali, negozi, start-up e street artist impegnati a riempire qualsiasi spazio lasciato libero da ex fabbriche e magazzini. Stesso trattamento anche per le antiche residenze vittoriane del quartiere, rimesse a nuovo con un bel lifting e pronte a ospitare un plotone di giovani professionisti e creativi. Le case più immortalate di Cape Town sono tuttavia altrove, tra le strade acciottolate del rione di Bo-Kaap, sulle pendici di Signal Hill. Edificata nel ’700 per ospitare schiavi e prigionieri a uso manodopera in arrivo da Malesia, Indonesia e altre parti dell’Africa, l’area – a prevalenza musulmana – era nota un tempo come “quartiere malese”. Alle abitazioni si affiancarono le moschee, la più antica delle quali, intonacata di verde, situata in Dorp Street e conosciuta come Auwal, risale addirittura al 1740. Al civico 79 della stessa strada si narra vi sia invece la proprietà più antica di Bo-Kaap, conosciuta come “De Schotschekloof” e risalente al 1707-1708, mentre l’edificio al 71 di Wale Street, che oggi ospita il Museo del quartiere, è probabilmente il più antico della zona nella sua forma originale. Se è vero che anche qui sta bussando la gentrificazione, l’atmosfera di Bo-Kaap ha ancora un volto autentico. Tra le case gioiosamente policrome (rosa, blu, verde, giallo…) in stile georgiano e coloniale, si chiacchiera, si flirta, si cucina, si fa il bucato. E proprio il cibo è un fondamentale indicatore dell’identità del quartiere: nella vita quotidiana, durante le tante feste religiose – come il Ramadan e l’Eid –, dai riti di passaggio alle celebrazioni di ogni genere. Curcuma, cumino, coriandolo, cannella e chiodi di garofano si danno appuntamento nelle ricette speziate della cucina “Cape Malay”, risultato scaturito dell’incontro di culture così diverse. Bobotie (carne macinata speziata cotta al forno con un topping di uova), samosa, curry con carne e frutta secca… appassionarsi è un attimo. Poi c’è un’altra Cape Town. Non quella di Instagram, delle brochure patinate o dei blog di viaggio di tendenza. Ma che sarebbe altrettanto necessario conoscere. Perché ci sono almeno un paio di modi per approcciare questa città o più in generale il Sudafrica.

tra il centro e signal hill, il quartiere multicolore di bo-kaap prende il nome dall’espressione afrikaans: “sopra il capo”.

stazione ferroviaria della cantina rickety bridge, franschhoek: tour di degustazione.

kirstenbosch national botanical garden.
Il primo, quello dello struzzo, consiste nel mettere in letargo qualsiasi accenno di dissonanza cognitiva e godersi lo show di una delle città più goderecce e oggettivamente appassionanti del continente. Il secondo, meno popolare e ancor meno pubblicizzato, consiste nel prendere coscienza dei ciò che quasi mezzo secolo di segregazione razziale, nota come apartheid, ha inflitto ai sudafricani e imparare la lezione. Nello specifico la decisione va presa con qualche minuto di anticipo sull’atterraggio al Cape Town International Airport, perché a circa un paio di chilometri dalla pista sarà impossibile non notare la sagoma di Khayelitsha, una delle township più vaste del Sudafrica: chi dice un milione, chi azzarda addirittura 2 mln di abitanti. I township sono quegli agglomerati di periferia urbana, sovraffollati e cresciuti senza regole come tessere di puzzle impazzite, abitati da povertà assoluta, baracche e container, crimine e mancanza di prospettive. Il loro scopo era invece chiarissimo: “ospitare” la popolazione “di colore” fatta sloggiare dalle città a beneficio dei “bianchi”. Un mondo perduto? Forse no, perché sono sempre di più coloro che non si rassegnano. Come i ragazzi dietro il 18 Gangster Museum (18gm.co.za) museo-progetto unico in Africa nato con il nobilissimo scopo di fornire ai giovani e giovanissimi del posto alternative possibili al gangsterismo e, allo stesso tempo, far conoscere agli ingenui come noi la realtà delle township con itinerari guidati che ricorderemo a lungo. Idem come sopra per Juma Mkwela, nato in Malawi, residente a Khayelitsha e convinto sostenitore che turismo e street art possano impattare positivamente le township mettendo in relazione viaggiatori e comunità locali. Ergo i suoi tour (jumaarttours.co.za), di un paio d’ore o anche di un’intera giornata, per incontrare gli artisti di The Story Room Creatives (the-story-room-creatives.weeblysite.com), il coro gospel Isibane se Africa sibaneseafrika.org), bere un caffè da Koffee Khaltsha (instagram.com/koffeekhaltsha) e fare la spesa in un mercato locale. Se Khayelitsha è l’esempio più manifesto della lotta tra il bene e il male, tra resilienza e abbandono, District 6, in pieno centro, necessita un’interpretazione. Apparso sulle mappe nel 1867, il quartiere era un vibrante melting pot culturale, etnico, professionale e religioso che riuniva sotto gli stessi tetti, all’epoca piuttosto malandati, africani, indiani, ebrei e immigrati europei giunti sin qui in cerca di chissà cosa o di chissà chi. A dispetto delle differenze, anche di classe, per un secolo andarono tutti d’amore e d’accordo; poi arrivò il 1966, il governo dichiara District 6 “zona bianca” imponendo lo sfratto a 60 000 residenti colpevoli di non avere la pelle abbastanza chiara. Molte delle loro case furono demolite. La fine dell’apartheid significò l’inizio di un nuovo corso per District 6 – oggi mix di terreni vuoti, edifici sopravvissuti e progetti di riqualificazione – con un processo di restituzione delle terre agli ex residenti o ai loro discendenti. Questo e molto altri vi raccontano con parole e immagini in via Buitenkant, nei molteplici spazi del District 6 Museum (district six.co.za), un simbolo di rinascita che ha appena compiuto trent’anni. Tra le guide, c’è ancora chi faceva parte di quei 60 000: le ascolti, rifletti. Poi cammini fino a Sea Point, ti siedi sugli scogli sferzati dal vento e osservi in rispettoso silenzio il disco rosso del sole immergersi tra le onde dell’oceano. Buonanotte Cape Town.