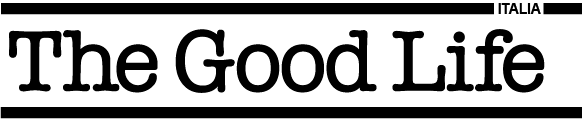Bangalore: la nuova Silicon Valley
A prevedere il destino di quella che un tempo era la città-giardino d’India per eccellenza, si dice sia stato Jawaharlal Nehru, il primo capo e visionario del governo post-indipendenza, che la definì “città del futuro”. Bangalore è stata poi ribattezzata dalla città dei laghi (ne conta quasi 200) alla città con aria condizionata incorporata, per il clima piacevole: si trova nello stato del Karnataka, nella calda India meridionale, ma è accoccolata nel cuore dell’altopiano di Mysore, che fa parte del più grande altopiano del Deccan, altitudine media 900 m. Ma oggi è detta la Silicon Valley indiana, ospitando oltre 12 mln di persone, (quattro volte quella californiana), compresi lavoratori di Google, Amazon, Oracle, Wipro, Infosys, Ibm. Quinta città più grande del Paese, nel suo passato si sono succeduti imperatori Vijayanagar e sultani Moghul, quindi gli inglesi. Come gran parte del Sud, le dinastie si alternarono anche nel creare bacini artificiali che favorissero l’irrigazione, la percolazione e la ricarica delle acque sotterranee. La storia della città è legata a quella della sua acqua: durante l’era coloniale si rese necessario convogliarla dall’esterno, arrivando fino al lontano il fiume Cauvery. Con l’avvento di acqua corrente e urbanizzazione, i laghi furono abbandonati per fare spazio a stadi sportivi e centri commerciali. Ma negli ultimi anni, il tema della scarsità d’acqua e i rischi per le sostanze inquinanti che filtrano nella falda hanno portato alla rinascita di molti bacini e aree verdi. Come si è arrivati a questa svolta? Radhika Viswanathan, ricercatrice della Dakshin Foundation, parte della fondazione moderna della città, nel 1537, che ancora oggi corrisponde al nucleo più antico, le aree “pete”, quartieri identificati da attività economiche: Akkipete per i commercianti di riso, Balepete per i fabbricanti di braccialetti, Kumbarapete per i vasai, Chikkapete e Nagarthpete per i commercianti di tessuti: «Una grande comunità, manifatture e negozi, che si sono reinventati». Il fatto, inusuale, che un’antica comunità sopravviva nel cuore della città, spiega la particolarità dello sviluppo di Bangalore: «Da un punto di vista demografico, negli ultimi 20 anni è che Bangalore ha capovolto la frittata, per così dire, sviluppando quartieri periferici divenuti più importanti del centro. Non è un caso che i luoghi simbolo dell’It e della Silicon Valley cittadina siano in periferia come Marathahalli e Whitefield».

l’orto botanico è un simbolo dell’originaria simbiosi tra natura e città di Bangalore.
A salvare Bangalore, rispetto ad altre megalopoli indiane che hanno vissuto una rivoluzione nel giro di pochi anni, secondo Avinash Krishnamurthy, direttore del Biome Environmental Trust, è stato anche l’atteggiamento della popolazione, che ha lottato per preservare i luoghi simbolo della sua identità di citta giardino, come il forte di Tipu Sultan e il palazzo estivo con i suoi giardini. Il Palazzo di Bangalore, in stile Tudor, con le torrette circolari ricoperte di edera e le aiuole ben curate. O il parco di Lal Bagh, il cui nome è un omaggio alla sua profusione di rose rosse: ospita la più grande collezione indiana di rare piante e alberi tropicali e subtropicali provenienti da Europa, Afghanistan e Persia, ma anche un lago e un giardino bonsai: «Noi indiani spesso non proteggiamo adeguatamente il nostro patrimonio. Ma a Bangalore è sorta una maggiore consapevolezzae. E il suo il patrimonio artistico, storico e culturale è intrinsecamente legato a quello naturale». La salvaguardia di uno e dell’altro vanno di pari passo. L’esempio perfetto è Namma Ooru, Namma Neeru, progetto di un collettivo di artisti che ha ricreato artisticamente la situazione idrica di Bangalore alla stazione della metropolitana di Cubbon Park, l’amato polmone verde cittadino: tubature, pozzi e altri sistemi idrici diventati invisibili a causa di strade, marciapiedi ed edifici. Il luogo è simbolico perché Cubbon Park, che oggi conta 65 pozzi ed è frutto di un progetto di rinascita urbana nato appena prima della pandemia. In parte, è la situazione di crisi a spingere all’azione, ricorda una delle massime esperte del rapporto tra natura e artificio a Bangalore, Harini Nagendra, docente, ecologista, autrice di Nature in the City: Bengaluru in the Past, Present, and Future (Oxford, 2016). La scorsa estate la città si è trovata senza acqua, con manager e companies costrette a razionare l’uso degli sciacquoni esattamente come gli abitanti dello slum.

il recupero delle acque reflue e la bonifica dei bacini inquinati è una priorità cittadina.
Secondo alcune stime, potrebbe restare senz’acqua entro dieci anni: «Le origini della crisi idrica risalgono al 1890, quando Bangalore iniziò per la prima volta a importare acqua convogliata da fonti lontane fuori città. Fino ad allora i laghi e le zone umide erano protetti, considerati sacri, mantenuti e utilizzati. In seguito diventarono luoghi in cui scaricare i rifiuti e preziose aree speculative da riempire e urbanizzare». Così, la città è cresciuta a spese di laghi e zone umide. S’è aggiunto il climate change, con temperature in rialzo e piogge scarse o imprevedibili: «Durante i monsoni si allaga perché l’acqua non ha nessun posto dove sgorgare e non può filtrare nel terreno perché gran parte della superficie è cementata. D’estate la siccità prevale, perché i livelli delle falde acquifere si stanno impoverendo senza possibilità di ricarica. L’inquinamento atmosferico e il calore sono problemi più recenti, risalenti agli ultimi due decenni, legati all’aumento dei veicoli, delle costruzioni e dell’abbattimento degli alberi». Ma la speranza c’è. I laghi nella periferia urbana possono essere ripristinati, com’è avvenuto per il lago Puttenahalli, a Jp Nagar. E se la collettività ha dovuto accettare soluzioni mai prese prima, come il trattamento delle acque reflue, le autorità hanno iniziato a lavorare seriamente a piani per la conservazione dell’acqua piovana, ma anche per la protezione di laghi, pozzi e acque sotterranee. «Bangalore un tempo era una kalyananagara, “una città di laghi”. Dobbiamo recuperare questa immagine perduta, tornare a vederla come una città d’acqua, resiliente per quei milioni di cittadini che la chiamano “casa”».