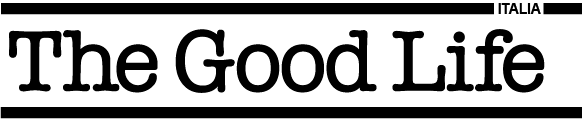L’elogio della follia di Peter Brunel
Peter Brunel è pazzo. Un pazzo buono, intendiamoci. Ma pazzo. E che sia uno chef in fondo è solo un’attenuante. Solo un pazzo può pensare infatti di dedicare in un ristorante della Busa – così viene chiamata questa zona del Garda trentino («Il Garda più bello, molto meglio di quello veneto e di quello lombardo», mi ha detto poco prima il tassista che mi ha condotto in questa villa appena fuori Arco. Campanilismo o consapevolezza?) – un intero menu degustazione – il Priore – a Gabriele D’Annunzio. Brunel, che un po’ il Vate evoca e ricorda, si è messo a studiare i messaggi che il poeta abruzzese lasciava su certi bigliettini in epoca pre-post-it alla governante Albina Becevello, detta “suor Albina”, che comandava la schiera di cuoche del Vittoriale atte a servire una fame con gli anni sempre più esigua e capricciosa. Messaggi audaci, commissioni confidenziali di cibi per occorrenze salaci: “Cara Albina, più tardi avrò una donna bianca su lino azzurro. Le donne bianche, dopo gli esercizi difficili, hanno fame…”. Oppure più banali menu per un pranzo con tre amici alle ore 13 (“antipasti, i fidelini, un secondo di pesce o di carne…”). Avvertenze rudi e definitive, come quando le intimava: “Bisogna che tu abbia cannelloni pronti in ogni ora del giorno e della notte”. Cannelloni, l’esatto contrario di quello che i futuristi di rito gastronomico più o meno negli stessi anni ritenevano fosse il cibo giusto per l’italiano contemporaneo, poco disposto secondo loro a farsi rallentare nella sua marcia verso un fulgido metallico avvenire dalla zavorra dei carboidrati. Naturalmente Brunel, il pazzo, propone i cannelloni, anzi i Can-nel-lo-ni – scandiamo bene accidenti – a un certo punto del percorso dannunziano, candele di grano duro e con ripieno di vitello, pomodoro e una salsa acida che, mi confesserà una chef amica che nella cucina di Brunel ha lavorato, «Prepararla è un vero incubo, impazzisce così facilmente». Pure lei, direte voi. Nel menu dannunziano anche il tramezzino – con tonno, uovo, lattuga e olive – a cui il Vate dette il nome quando nel 1926 lo provò al caffè Mulassano di Torino, perché faceva da intercapedine tra la colazione e il pranzo; e il risotto alle rose con cui lui sedusse Eleonora Duse, decisamente all’altezza di una simile smisurata ambizione; e l’agnello croccante delle mitologiche costolette di Albina. Infine la mondia di arance al liquore Aurum. E il cremino Fiat di cui D’Annunzio disegnò il packaging. Ma non è solo per questo dannunzianesimo spinto e perfino ardito che Brunel è pazzo.

outdoor personalmente curati dallo chef. Ph: Marco Favali

indoor personalmente curati dallo chef. Ph: Marco Favali
C’è anche il fatto che ha deciso di fabbricare un altro menu degustazione dedicato alla cucina Nikkei, quella in cui Giappone e Perù si abbracciano, e puoi mangiare un gazpacho con pomodoro, peperone, latticello e scampi, un vitello tonnato senza tonno, ma con patate e asparagi in crema, una lugubre, ma elettrica ceviche trentina con trota, polpo, mela, sedano e limone annerita dalla seppia e dal carbone, un nigiri al foie gras e un manzo con limone, olive e shiso rosso. Di questo modo di mangiare a cavallo tra due continenti in un terzo, Brunel s’innamorò a Barcellona, e non se n’è mai più disamorato. E neppure solo per questo, alla fine. Il fatto è come Peter concepisce il suo ristorante, a sua immagine e somiglianza, con tutte le sue passioni stipate dentro, e sono tante, intense e assai diverse: e D’Annunzio, e il Vittoriale, a cui il ristorante s’ispira dichiaratamente; e la cucina Nikkei, e poi le Porsche, a cui ha dedicato una sala apposita – in cui mangerò io, che un’automobile nemmeno la possiedo –, e Fortunato Depero che nella non lontana Rovereto operò, e Bruno Munari, e l’alta fedeltà, e gli orologi che lui stesso costruisce nei suoi momenti liberi (quali, di grazia?) dentro il garage e quindi per sineddoche il tempo tutto, e certi giochini primo ’900 che lui dà ai bambini dei clienti per evitare che si trastullino con l’iPhone e che finge che siano delle sue figlie per evitare di doverli regalare a tutti, come aveva preso a fare, e quegli affari sono piuttusto costosi. E certo, c’è un bel po’ di ego in tutto ciò, e pezzi di autobiografia regalati, e l’idea di fare della cucina gourmet una performance di body art alla Marina Abramović, in cui lui si mette a nudo e offre di sé molto di più di quanto certi chef austeri e dottorali e salvatori del mondo abbiano l’uso di fare. E questo io lo chiamo genio, un’ossessione che brucia e divora, il pensiero che “una cena è una cena è una cena”, che deve essere un’esperienza olistica, totale, da tutto o niente. Un all-in pazzo e disperatissimo eppure giocoso, e Brunel mi perdonerà se per una volta cito il Leopardi e non il Vate. Peter richiede lo stesso impegno furioso ai suoi collaboratori («Chi è accanto a me deve interpretare il lavoro come una missione») e anche al cliente, che deve avere la stessa voglia di venir qui che ha lui di accoglierlo («Io voglio star fuori dai circuiti turistici, per questo resto chiuso la domenica. Questo è un posto di destinazione, devi venirci apposta»).

ricordo di lofoten: alici marinate, h2o di mare, uova di aringa e peperone piquillo. Ph: Martino Dini

agnello bagnato in h2o di mare con carote e cavolo stufati. Ph: Martino Dini
Peter ha disegnato un mondo tutto suo, progettando ogni singolo pezzo del ristorante, se è vero che un uomo si giudica dai dettagli, lui è un caso da Cassazione. Brunel immagina per il suo ospite un’esperienza fuori ordinanza che parte dal parcheggio e finisce allo sparcheggio, anzi meglio se il giorno dopo, quando il cliente deve ripensare al tempo passato qui e pensare che sì ne è valsa la pena. Per dire, la cucina a vista riproduce quella di D’Annunzio o dovremmo dire di Albina al Vittoriale, c’è una foto a dimostrarlo, naturalmente con le comodità e le tecnologie di oggi, perché va bene la filologia, ma mica siamo qui per farci del male. Poi molti tavoli hanno accanto un salottino privato, così che il cliente ha due sedute a disposizione. Poi ci sono sedute ad altezze differenti nei vari punti del locale per i vari momenti della serata, e un tavolo per gli amici che passano e non trovano posto ma devono comunque poter essere sfamati gratis, e lampade da spigolo per risparmiare spazio, e bagni con décor differenti per donne e uomini e così via. Brunel ha 48 anni ed è originario della Val di Fassa, quindi trentino dolomitico. Ha conquistato la sua prima stella a 28 anni, 20 anni fa, a Villa Negri di Riva del Garda. Ha lavorato poi in Toscana, al Palagio59 di Rignano sull’Arno e poi a Borgo San Jacopo, a Firenze, un ristorante della famiglia Ferragamo, dove scoprì tra l’altro la passione per la cucina Nikkei e per l’abbinamento di questa ai cocktail. La sua cucina è tecnica e colta ma al contempo una faccenda di mano, di scarpette, con brodi da sorbire facendo un po’ di rumore; attinge a una memoria che non è rimuginativa e tassonomica, ma emozionale, quindi tutt’altro che perfetta (è un complimento). Mi piace come Peter pone il vegetale alla ribalta, lo esalta, lo vezzeggia con una specie di metodo Stanislavskij, che mette in contatto fuori e dentro, realtà e finzione, essere e non essere. Come lo renda socio della proteina e non un subalterno. La sua valigia è piena di adesivi, ma la sua è spontaneamente, alla fine, una cucina di territorio, ciò che la rende ovviamente sostenibile: in ogni piatto, anche il più citazionista, il più intellettuale, spuntano ingredienti di piccoli artigiani locali: mele, formaggi, rafano bianco, le uova che Brunel venera (di gallina, ma anche di trota e di storione). Siamo in Trentino, che diamine. Nel frattempo dopo i dolci della fiorentina Maria Novella Salani, la cena è finita. Peter mi firma con dedica il menu formato extra-large, nello zaino non ci starà, lo porterò con me a mano. «Devi tornare, ci sono un sacco di cose che non ti ho detto». Capito come?