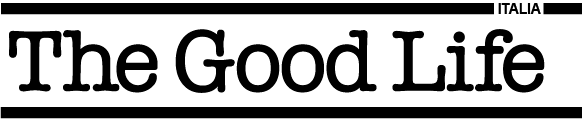Maddalena Casadei, cari boomer fate largo
L’headquarter di Maddalena Casadei è un piccolo studio ben curato al piano rialzato di un palazzo in stile vecchia Milano. Nata nel 1976, ex pallavolista professionista in serie A e B, dopo una laurea in Architettura e un lungo periodo trascorso lavorando al fianco di James Irvine, si occupa con il proprio studio di design di prodotto, furniture e art direction. Oltre a essere una progettista stimata, però, Maddalena è una sineddoche in carne e ossa dei designer della sua generazione, schiacciata tra la precedente, che definisce «poco inclusiva», e la successiva: quei ventenni «dalla grandissima capacità comunicativa» con i quali è destinata sempre più spesso a misurarsi. Fin dai tempi dell’università, come tutti i suoi coetanei si è formata ascoltando il racconto dell’età dell’oro dell’architettura (a Ferrara, dove si è laureata) e del design italiano (a Milano alla Domus Academy), esploso a cavallo tra gli anni 60e 80, quando la generazione dei cosiddetti “boomer” «ha potuto provare, sbagliare e riprovare più di quanto sia stato consentito alla mia. Fino a quando è riuscita a lanciare quei prodotti che avrebbero fatto la storia». Si è trattata di una stagione di aperture di credito da parte degli imprenditori, fiduciosi, finanziariamente prodighi e propensi al rischio. Ma che nell’epica ricostruzione e autoricostruzione retrospettiva ha spesso oscurato i non pochi inciampi, errori, fallimenti di nomi pur entrati nella sto-ria del design. Nonostante tutto, Maddalena, «con grande determinazione ma anche fatica», sottolinea, ha fatto sentire la sua voce contando collaborazioni con aziende come Ichendorf, Marsotto edizioni, Fucina, Kettal e Pretziada. La gavetta, lunga e ricercata, è servita sia per imparare la professione, approfondendo il design di prodotto, sia per fare fronte economica-mente a una città in rapida trasformazione come Milano, dove, lo stile di vita cosmopolita esibito all’esterno è più una vetrina a uso dei turisti che della maggior parte dei milanesi adottivi come me, arrivati dalla provincia e abituati a fare vita di quartiere». Così, Maddalena ha aperto il suo studio solamente da cinque anni. «Ed è per questo, forse, che li definiscono ancora una “designer emergente”. Ma non lo sono né per esperienza né per età. D’altronde, non mi vengono in mente altri ambiti lavorativi dove per definire una professionalità si ricorra a queste due caratteristiche. Probabilmente è un escamotage utile alle riviste di settore per lanciare novità. Ma trovo che gli appellativi “giovane” o “emergente” siano piuttosto anacronistici».. La sensazione diffusa tra i designer nati e cresciuti a cavallo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, come testimonia Maddalena, è quella di essere a volte osteggiati». «Almeno il 30% delle aziende sono legate a progettisti che faticano a concederci spazio». Per ottenere un quadro completo del fragile sistema design, a questo ostruzionismo generazionale, forse inevitabile, va aggiunta la consueta discriminazione di genere. «Collaboro sempre più spesso con imprenditori, miei coetanei, con cui si riesce a parlare di progetto e a instaurare un rapporto di stima reciproca. Ma non nego che esistono ancora molte realtà, soprattutto in Italia, dove le donne sono difficilmente considerate perchè si crede non siano in grado di produrre design di livello industriale di qualità: in quel caso sembra di ritornare ai tempi di Charlotte Perriand». Nei primi decenni del secolo scorso, ma ancora nel secondo dopoguerra, anche le progettiste più talentuose, infatti, erano non di rado confinate al design di tessuti o di ceramiche o co-strette a vivere all’ombra dei più famosi compagni di lavoro e spesso di vita. Soltanto da qualche anno le cose sono iniziate davvero a cambiare. «Ho molta stima di personaggi come Patricia Urquiola o Paola Navone, che pur in questo panorama non favorevole sono comunque riuscite a farsi valere». Il problema non finisce qui, però, perché a queste convinzioni radicate nel


tessuto sociale – che, anche se con lentezza, fortunatamente si stanno estinguendo – andrebbe sommata una certa omologazione aziendale che rende realtà un tempo fabbriche di idee, oggi fabbriche di riedizioni. Maddalena non nega, tuttavia, una carenza di audacia da parte delle aziende del design. «Manca l’imprenditore o forse mancano linee guida chiare e indicazioni precise per noi designer. Le grandi aziende vengono ormai acquistate da fondi che non hanno niente a che fare col design e che pensano di gestire tutto alla stessa maniera, come fossero brand di cosmetici o di food. Con il furniture non penso si possa adottare una pura logica di investimento/ritorno: è un investimento a lungo termine che necessita di una visione e di un intuito personale anche da parte del progettista. È finito il tempo del matrimonio “azienda-designer” e, per fortuna, noto come nuove realtà e nuove generazioni d’imprenditori iniziano a non vedere più il grande nome come unico elemento chiave». Come ogni crisi di coppia che si rispetti, la responsabilità di questo stato di cose non sta tutta da una sola parte. Anche noi progettisti dobbiamo lasciare stare la chimera della grande azienda e investire su scenari nuovi, più aperti e coraggiosi, e soprattutto su persone disposte a instaurare un rapporto umano e favorire il più possibile il dialogo. Quest’ultimo è fondamentale, da tutti i punti di vista: un progetto deve essere parte di un percorso di scambio con l’azienda, basato su obiettivi condivisi e non più scandito esclusivamente da calendari e scadenze sempre più fitti e intricati. Inoltre, non è più possibile lavorare per comparti-menti stagni e singolarmente: i designer per primi devono fare rete e coinvolgersi. Vanno anche menzionate le istituzioni culturali, che spesso sono troppo chiuse e non riescono a dare voce a una cultura del progetto trasversale o anche soltanto dal respiro internazionale. Sarebbe poi auspicabile la riduzione di una eccessiva frammentazione delle prososte fieristiche che, sorattutto ora, in una fase di ripartenza, necessiterebbero di ulteriori energie economiche e progettuali». Respirare aria internazionale sembra non fare altro che aumentare la voglia di espatriare, all’apparenza l’unica strada percorribile se si è alla ricerca di un giusto riconoscimento. Il fatto che per essere nobili a casa nostra ci si debba nobilitare prima all’estero, credo sia una caratteristica tipicamente italiana, soprattutto nel mondo del design», afferma Maddalena, che all’estero ha trovato anche un’occasione accademica come visiting professor all’Ecole cantonale d’art de Lausanne. «Lavorare con le realtà straniere è più semplice, perché non cercano il nome e si concentrano soprattutto su altri aspetti». Per Maddalena, però, Milano rimane la scelta giusta, sotto molti aspetti. «Qui ho la possibilità di costruire relazioni umane e professionali alimentando uno scambio culturale molto eterogeneo. Quando è scoppiata la pandemia era diffusa la preoccupazione che potessero togliere alla città quel suo primato storico di “capitale del design”.
Personalmente, sono convinta che questo non accadrà mai. È qui che troviamo la maggior parte della produzione. E ciò che dà origine al Salone del mobile sono anzitutto la quantità e la qualità di aziende disseminate in tutto il Nord Italia: una realtà industriale difficilmente replicabile nel resto del mondo». Lo scettro del design alla città che, si dice, “non si ferma mai” pare non esserle stato ancora sottratto, sebbene la tripla pausa forzata del 2020, 2021 e forse 2022 – interrotta per il momento soltanto dal Supersalone dello scorso settembre – ha rimescolato le carte. Spiega Maddalena. «A causa degli stop dovuti alla pandemia, le aziende si sono accorte che possono presentare le collezioni in modi sino a ora considerati soltanto collaterali: non più solamente in presenza, quindi, ma anche attraverso i social network, ridefinendo così anche le tempistiche di lancio dei prodotti. Questa decelerazione nella corsa a tutti i costi alla novità sta restituendo la possibilità di approfondire e affinare le idee. E mi auguro che possa portare a un miglioramento in termini di qualità e ricerca. Prima di questo grande cambio di rotta ricordo newsletter zeppe di novità. Ma è difficile progettare così tanti prodotti insieme mantenendo un certo livello quilitativo. Meglio meno, ma con maggior cura. Non possiamo lanciare sul mercato progetti a getto continuo se, come diciamo, vogliamo aspirare a creare prodotti che durino nel tempo e abbiano un potenziale iconico…». Insomma, lasciare entrare nel circuito di questa folle corsa quotidiana del design una safety car ogni tanto non sarebbe una cattiva idea. Pnche perché, magari, ci consentirebbe di tornare a goderci con più calma la bellezza del panorama.