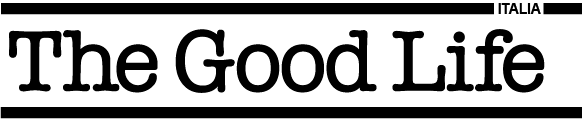Piero Lissoni: dopo i boomer, il diluvio?
A Piero Lissoni probabilmente piace il calcio totale. Brianzolo di Seregno, classe 1956, architetto dal 1986, ha progettato hotel a Baden Baden e flagship store a Istanbul, resort negli Emirati Arabi Uniti e yacht extralusso per il mercato cinese, riconvertito ospedali a Miami e allestito mostre a Milano. Recitare il rosario dei brand per i quali ha disegnato o di cui è art director è un esercizio tantrico, che gli vale tra i detrattori l’appellativo di “commerciale” del quale lui, probabilmente, andrebbe fiero: Alessi, Antrax, Alpi, B&B Italia, Boffi, Cappellini, Cassina, per citarne alcuni; e poi De Padova, Fantini, Flos, Living Divani, Lema, Lualdi, Porro, Kartell, Knoll e via snocciolando. Alto, sottile, irrequieto, stretto in un “dandissimo” completo blu, ci accoglie senza cerimonie nello studio milanese (l’altro è a New York) come un lombardo di quelli svelti, che ti tolgono il fiato. Ma poi cede, si abbandona. E con una voce bassa, sottile, gioca a tutto campo a fare Gru, il “cattivissimo me” a capo dei minions: gli “scagnozzi“ cinematografici più famosi del Pianeta. I sassolini nelle scarpe non gli mancano. E lui se li toglie. Partiamo dalle città. Tratteggiamo il quadro offerto dall’Agenda 30 delle Nazioni Unite. I centri urbani consumano il 75% dell’energia e producono oltre il 50% dei gas serra. Bruciano immani risorse idriche e alimentari e non ne producono. Sono le più esposte al cambiamento climatico, all’inquinamento, alle pandemie. E approfondiscono le diseguaglianze sociali. È nelle città, quindi, che si vince o si perde la battaglia del futuro, si dice. Fin qui tutto bene. Ma appena gli chiedo se l’architettura, o l’urbanistica, salveranno il mondo, non concede nulla alla retorica: «C’è chi lo dice… La realtà è che se il design ha un suo equilibrio, una sensibilità naturale, per così dire, lo stesso non vale per l’architettura. Il design lo scegli tu, l’architettura la subisci». Bando, quindi, alle utopie urbane: «Alcuni dei nostri maestri, o presunti tali, pensavano che la cattiva architettura peggiorasse le nostre vite e la buona le migliorasse. Non sono d’accordo: le città si disegnano da sole. Non c’è urbanista al mondo che abbia disegnato una città come si deve. In cento e più anni abbiamo dimostrato di essere incapaci. Gli architetti possono disegnare edifici più o meno belli, più spesso brutti. Ma non sono taumaturghi, semmai strani animali da tenere chiusi in uno zoo…», chiosa ridacchiando. Esempio scontato, il quartiere Zen di Palermo di Vittorio Gregotti: «Un’architettura punitiva», dice, le cui pretese di emancipazione sociale, diversamente da quanto sostenne il progettista, «non fallirono soltanto per colpa della politica. Bensì per non avere tenuto presente la difficile condizione economica, sociale, culturale di coloro cui si rivolgevano, ai quali premeva più che altro avere un tetto sopra la testa. Fu un errore di moltissima architettura del dopoguerra». Si può dire lo stesso di mostri sacri come Aldo Rossi o Carlo Aymonino, studiati in tutto il mondo? «Certamente sì. Alcune loro architetture erano ideologicamente corrette, ma strutturalmente sbagliate. La Stecca al Gallaratese, a Milano, è un bellissimo oggetto di architettura, che nasce come una casa di ringhiera. Ma chi era cresciuto in una casa di ringhiera l’avrebbe bombardata, perché riproduceva un vissuto da cui si voleva distaccare».


Il mix si predica, ma non si pratica
L’enfasi sulla condivisione, sulla comunità, sulla piazza in cui vivere insieme, che oggi torna di moda, rischia spesso di non fare i conti con la realtà: «Bastarono quattro soldi e due automobili per sfasciare tutto…». Eppure, sempre a Milano, con le Residenze Carlo Erba, anche il celebre architetto americano Peter Eisenman ha ripreso lo stile della casa di ringhiera, sebbene in chiave extralusso… «Se uno è così tonto da spendere un sacco di soldi per una casa di ringhiera, sono fatti suoi…». Fuori due. Ma non si creda: benché tenti di nasconderla, anche Lissoni ha un’anima. Preferisce apparire cinico, piuttosto che ipocrita: «Mi considero un progressista del mestiere. Devo riconoscere, però, che quando gli architetti hanno disegnato case popolari hanno spesso adottato una visione ideologica, post-sovietica». Eppure, per restare a Milano, i Gio Ponti, i Piero Bottoni, i Luigi Figini hanno disegnato quartieri egregi, vivibili e all’avanguardia. Era edilizia pubblica ed erano i durissimi Anni 50… «L’errore fu abbandonare quel modello umanistico per uno ideologico». Prendiamo Il Corviale, a Roma: è un caseggiato di cemento progettato negli Anni 70, monoblocco, lungo un chilometro e mezzo, popolato da 4 500 abitanti e battezzato significativamente “Il serpentone”: «Come puoi pensare ci si viva bene?». Ma tanta enfasi odierna sulla rigenerazione urbana non nasconde spesso la pura e semplice speculazione immobiliare, che fa schizzare il costo della vita ed espelle dai quartieri larghi strati sociali? Oltre agli oneri di urbanizzazione, verrebbe da dire, i costruttori dovrebbero forse pagare anche oneri di socializzazione, che salvaguardino davvero il mix sociale. In fondo, per secoli i ricchi hanno vissuto fianco a fianco con meno abbienti… Un assist perfetto per “cattivissimo me”: «È vero. Ma checché se ne dica, la società oggi è molto più classista di quella dei nostri genitori». Il mix si predica, ma non si pratica. «Al di là della retorica dell’inclusione, basta vedere che cosa è successo al quartiere Isola di Milano: tutti quei mondi che a parole avrebbero dovuto essere integrati, man mano che sono arrivati i nuovi yuppies sono spariti». E, sempre a Milano, le cose non andranno diversamente a Nolo o in Porta Romana: «Se non vogliamo raccontarci fiabe perbene, quando tra dieci anni in Porta Romana arriveranno altri headquarter come quello di Moncler, chi aveva pagato la casa da 800 euro al metro quadrato sarà spazzato via, perché anche la trippa che mangiava in trattoria a pochi euro gli costerà una cifra. Parliamo di sharing, ma è per condividere la foto della pizza con gente che si trova chissà dove. Per il resto, c’imbarazza persino salutare il vicino». Le nostre speranze di sinceri democratici, preso congedo dall’architettura, cercano ormai rifugio nel design. Ma il primo a cadere è Enzo Mari: «Un dandy milanese che parlava di autoproduzione costruendo sedie con quattro assi. Mentre il falegname siciliano emigrato al Nord non vedeva l’ora di comprarsi in Brianza un letto fatto e finito…». La sola autoproduzione rivoluzionaria è stata quella di Ikea. Ma anche qui, nessuna pietà: «Dal punto di vista del design, un bluff colossale. Ma con un’intuizione geniale: vendere mobili a prezzi stracciati bypassando distribuzione e rivendita, circa il 45% del prezzo. Vai poi a sapere che controllo hanno di filiere che si trovano in Turchia o in Bangladesh…».
«Il Salone senza le aziende non è nulla. Ma il Salone, a sua volta, non è nulla senza Milano».
Tutta logistica e distintivo, insomma; ma una Amazon del mobile con cinquant’anni d’anticipo. Non ci resta che aggrapparci al Salone del Mobile di Milano: il regno del design “commerciale” nel senso più blasonato del termine. Azzoppato dalla pandemia nell’aprile del 2020, ha giocato il riscatto nel settembre del 2021, con il Supersalone curato da Stefano Boeri, direttore della Triennale di Milano. Mentre il 2022 lo ha visto scivolare da aprile a giugno. “Riscatto”, comunque, è una parola grossa, per Lissoni. La formula tra il popolare e il pop, basata su talk, eventi in fiera e allestimenti verticali “democratici” tutti uguali, non ha futuro: «Una tipica alzata d’ingegno di Stefano, perfetta per i giornali. Comunque sia, è servito a mostrare che Milano poteva ripartire. Una sorta di pre-accensione. Ma poi è la città a essere davvero ripartita, con i suoi locali, le sue iniziative. Per il resto è una formula che non avrebbe senso ripetere, a meno che le aziende vogliano suicidarsi: le imprese lottano per avere un’identità, non per farsi omologare da un allestimento. Anche qui è all’opera un approccio ideologico-progettuale. Il Salone senza le aziende non è nulla: una scatola vuota. Ma il Salone, a sua volta, non è nulla senza Milano: i negozi, le mostre, gli incontri, le installazioni. Semmai, dopo questo stop, potremmo attenderci più qualità, evitando che tutto scada in una Superfesta dell’Unità per cinque giorni. Nel nostro mondo, diversamente dalla moda, è fondamentale sedersi su un divano, toccare un tavolo, aprire un armadio. Prima di scegliere tra un divano in canvas da 5 000 € e uno da 15 000 € vuoi toccarlo, stai sicuro…». Il Supersalone, però, come già il Salone Satellite, ideato da Marva Griffin nel 1998, aveva anche l’ambizione di lanciare giovani designer. L’Italia è stata pioniera e caposcuola in passato. Ha regalato al mondo fuoriclasse: da Osvaldo Borsani ad Achille Castiglioni, da Gaetano Pesce a Ettore Sottsass, fino ad Alessandro Mendini. Oggi, nonostante 150 000 architetti, record per abitante in Europa, e 18 università, 15 accademie di belle arti e 11 istituti privati capaci di sfornare migliaia di designer, un italiano, per avere successo, sembra dover riparare all’estero. Mentre le nostre oltre 30 000 aziende finiscono spesso con il cercare oltreconfine i loro campioni: Ron Arad, Nendo, i fratelli Bouroullec, Michael Anastassiades… Per il resto si ricicla il passato. Sembra svanita, insomma, la polverina che combinava in una magica alchimia la creatività del designer e il fiuto dell’imprenditore.
LEGGI ANCHE: Emiliano Ponzi, l’illustrazione come un’ opera teatrale


«Molti giovani realizzano all’inizio un prodotto interessante, ma poi non danno continuità».
Non sono abbastanza bravi? O è la generazione pigliatutto di Lissoni a fare da tappo? «C’è chi pensa esista una sorta di Bilderberg mondiale del design il cui scopo sia tagliare fuori dal mercato i giovani. Ma vi ricordate quel film degli Anni 80: Sotto il vestito niente..? Ecco: “sotto il disegno niente”… Quando mi arrivano i curriculum o i progetti, li faccio vedere anche agli altri, in studio, per capire se il problema sono io: non è che sono diventato un vecchio t-rex che non sa far altro che azzannare piccoli velociraptor? La realtà è che spesso hanno fretta di apparire originali, autoriali, mentre sono scolastici. Ricordo una lezione di Renzo Piano al Politecnico di Milano. Il consiglio che diede agli studenti fu: copiate, copiate, copiate… e poi rubate… perché soltanto copiando e rubando potrà avvenire in voi un’evoluzione verso un linguaggio personale… saltasse fuori un Jasper Morrison, un Antonio Citterio, lo prenderei subito… Io sono sempre alla scoperta di un’opera prima. È fondamentale aprire nuovi filoni… il problema è che cosa succede con l’opera seconda… con la terza… molti giovani realizzano all’inizio un prodotto interessante, ma poi non danno continuità al loro lavoro. Non basta avere studiato design per essere un designer. Quando entri nella professione, ti accorgi che gli studi sono avanti anni luce rispetto a quello che ti hanno insegnato». Esiste poi un problema di serietà dell’insegnamento. «Alla laurea magistrale del Politecnico di Milano, dove insegno, su cinque tesi, ho dato il voto a due. Altrove, però, il design non s’insegna così. Parlo di scuole di Milano dove magari paghi una retta di 15 000 € all’anno. Ma anche di scuole all’estero celebrate, come quella di Eindhoven». Contro lo scolasticismo pretenzioso, riponiamo le nostre ultime speranze nel design di ricerca, orientato all’edizione limitata più che al prodotto industriale. Abbiamo casi italiani di successo, come il duo Formafantasma. Hanno sfondato all’estero, però… «Tu puoi inondare il mondo di oggetti. Ma non puoi costringere nessuno a comprarli. Esistono non più di cinque o sei aziende che possono permettersi di rieditare pezzi, magari con ritocchi irrilevanti. A volte funziona, si pensi al successo del Camaleonda di B&B Italia: un divano disegnato nel 1970 da Mario Bellini, allora in anticipo sui tempi, oggi in linea con il recupero di molta estetica di quel decennio. Più spesso, però, è un esercizio effimero, che nasconde una carenza di idee. Sperimentare, quindi, aiuta ad aprire nuove strade. Ma le aziende non sono scatole senza fondo. A un certo punto devi confrontarti con i loro vincoli e accettare il giudizio del mercato. Altrimenti partecipi soltanto a un gioco rivolto a una piccola cerchia intellettuale autoreferenziale. Io sono tra i pochi che hanno stroncato – in questo caso: nonostante il suo successo – la mostra Broken Nature curata nel 2019 da Paola Antonelli per la XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Costosa, con troppi progetti poco consistenti: cappelli-chador parasole contro il riscaldamento globale, computer riciclati come scrivanie… Una lettura che non sembra essersi davvero confrontata con le conoscenze scientifiche e tecniche contemporanee». Il tempo è scaduto. L’animal spirit brianzolo riprende il controllo. Sopravvissuti a stento, gettiamo un’occhiata alla porta. Tenera e pasticciona, ci aggredirà appena fuori una folla di Minions?